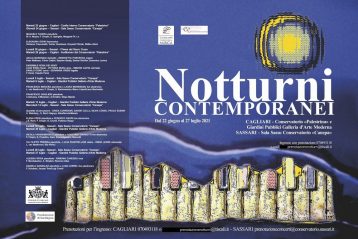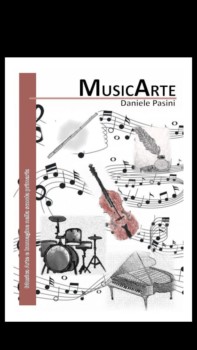Morte nel folklore sardo è una bella signora, vestita d’un manto scuro e con un tronco cavo per corpo. La notte passeggia per le vie del paese, seguita da chi di recente è stato sottratto alla vita. Tanto è forte il desiderio di rivedere i propri defunti, che qualcuno, ci raccontano le leggende, arriva per giunta a chiamarla sull’uscio della propria porta. Un gesto per lo meno azzardato perché con Morte in Sardegna non si scherza, tanto più che dove passa lei, cresce il pungente rovo della Vendetta.
D’altronde chi non lo sa, vendicarsi nella Sardegna tradizionale era un obbligo, tanto più quando Vendetta era invocata durante la veglia funebre dell’uomo di valore, morto per mano del nemico. Non era la moglie a chiamare vendetta, non era la madre o la sorella, erano le prefiche, per dirla alla sarda attitadoras.
Nessun desiderio di maternità, la figura delle prefiche la conosce tutto il Mediterraneo (e non solo): abitavano la Grecia, l’Egitto, l’Italia, la Palestina, Israele, la Siria, la Spagna, l’Albania ma anche la penisola arabica e la casa delle genti indio amerinde, insomma, dove c’era Morte era probabile ci fesse una prefica.
Solo le donne potevano essere prefiche – attitadoras in Sardegna e poco contava che fossero giovani e belle o anziane ed esperte, quel che importava veramente era che sapessero strappare con i propri canti, il sentimento dal cuore di chi ascoltava, e a leggere i commentatori che parlando di cosa sarde, ci riuscivano per davvero.
Erano tassello fondamentale di quei rituali atti ad affrontare Morte, che ieri era fatto di gruppo e non privato. La casa del morto che le attitadoras raggiungevano vestite di nero e giallo (in diverse località colore del lutto), era stata precedentemente preparata alla venuta di Morte. Il cadavere era steso in un letto o in una stuoia funebre con i piedi verso l’uscio, perché da lì sarebbe partito verso la sua nuova vita, le tende erano state tirate, le finestre chiuse dopo la morte e gli specchi velati, che lì vi si impigliavano le anime.
Piccole formicuzze scure e tozze, raggiungevano in silenzio e fila indiana la stanza del morto e il dolore veniva messo in scena. Non sempre avevano avuto rapporti con il defunto quando ancora era in vita, questo però non impediva loro di cantare lamenti coinvolgenti e strazianti.
Improvvisatrici stimate in tutto il paese, più intenso era il proprio canto, più grati si dimostravano i parenti del morto. Chi ha avuto la fortuna d’osservare queste professioniste all’opera le descrive acute e lancinanti, capaci di raccontare con parole diverse la vita e la morte di chiunque. Quando a morire era una giovane il recitativo era tenero e melanconico, quando Morte aveva deciso di portar via un giovane sposo, i lamenti parlavano della sua bellezza e della sua bontà e del futuro negato alla coppia. Le plumbee attitadoras avevano una parola diversa per ciascuno da scegliere in base al sesso, alla classe, all’età, alle qualità ed alle circostanze.
E la circostanza di cui ci interessa in questa sede era quella nella quale Morte arrivava violenta. Erano canti veementi e per renderli ancora più furiosi e densi si era soliti lasciare nella stanza la camicia del morto, ancora sporca del suo ultimo sangue.
“Allorché si tratta d’un capo di famiglia ucciso da un nemico, la sete della vendetta domina sugli altri sentimenti. L’odio contro l’assassino sostituisce i lamenti e l’amore per colui che non è più. Il desiderio di vendicarlo verrebbe immancabilmente in seguito a questi lugubri lamenti, se questo desiderio non fosse già troppo radicato nella natura dei sardi”, e Domenech prosegue nelle ultime pagine di Pastori e Banditi raccontando con quale abilità l’improvvisatrice è capace di risvegliare nell’ascoltatore il bisogno di vendetta, tant’è che a sua detta, non era raro che gli uomini sardi uscissero come saette dalle case omaggiate dalla presenza di Morte per portarla nelle dimore degli assassini.
“E capitato diverse volte che durante questa cerimonia dell’attito, uno dei parenti del morto sia corso dall’assassino, l’abbia ucciso con un colpo di pugnale o con una fucilata, gli abbia cavato il cuore o l’abbia decapitato e portato al morto il trofeo sanguinante, dicendogli: vedi gioiscine, non sei stato tu solo a conoscer la morte”.
Non è dato sapere quanto ci sia di vero in questa descrizione, in cui, è probabile, l’autore abbia ceduto al desiderio di pitturare fin troppo intensamente situazioni già di per sé forti, quel che conta sapere è che queste lamentatrici funebri, cantavano d’amore e di dolore, ma sapevano anche risvegliare Vendetta.
La lamentazione funebre era cosa riservata a tutti i morti, e Grazia Deledda in “La via del male” la descrive così.
“Nella cucina si svolgeva la ria, l’antica scena funebre, resa più caratteristica dal chiaroscuro dell’ambiente. Il focolare era spento, la finestra chiusa…”
“Le altre donne sedevano per terra, con le gambe incrociate, tutte avvolte nelle loro pesanti tuniche e il viso seminascosto dalle bende nere e gialle di lutto. Ogni tanto la porta s’apriva…”
“Nella cucina le donne si misero a piangere con frenesia:
due parenti del morto cominciarono sos attitidos, canti funebri improvvisati. Cantavano una per volta, e ad ogni versetto le donne rispondevano con un coro di gemiti, singulti e grida…”
“… ora che la vedova non era più lì, (le attitadoras diedero voce) a tutta la foga della loro inspirazione poetica.”
“Maledetto colui che ti ha colpito; maledetto. Maledetto: quante gocce di latte ho dato al morto, tante ferite ti trapassino il cuore, assassino!”
“Noi ci strappiamo i capelli, chiedendo vendetta al cielo. Sia maledetto il latte che nutrì il tuo assassino; spuntino rovi sul suo cammino!”
“Che la giustizia lo afferri e ne faccia strazio. Con sette colpi di pugnale bucarono il tuo cuore come si buca un pezzo di sughero: settanta anni ed altri sette duri la pena di colui che ti ha ucciso a tradimento.”
Un rituale antico egiziano, greco, etrusco, di cui ad oggi rimane poco o niente, vietato dal cristianesimo che scorgeva nel suo seno quel tanto di pagano che lo rendeva più che pericoloso.
Perché lo scopo, quello profondo de s’attitu non era quello di risvegliare Vendetta in chi ascoltava, quanto piuttosto quello di accompagnare il defunto lontano dal mondo dei vivi. I defunti sardi, è bene ricordarlo, avevano poco a che vedere con quelli cristiani la cui anima prendeva la prima coincidenza alla volta del paradiso o dell’inferno. In Sardegna le anime vivevano un lungo purgatorio “terrestre” e i vivi con s’attitu non facevano altro che difendersi dall’anima del defunto che amavano sì, ma pure temevano.
Coprire gli specchi, tener il letto con i piedi rivolti alla porta, agitare il fazzoletto bianco sul corpo del trapassato, aprire le finestre immediatamente dopo il decesso e poi richiuderle, graffiarsi e strapparsi i capelli durante la lamentazione, erano tutte operazioni apotropaiche di allontanamento del defunto, condivise dall’intera società.
Tutto aveva lo scopo di evitare il ritorno del trapassato dopo la morte: d’altronde il raggiungimento della pace definitiva dell’anima dipendeva anche dalla qualità ed intensità dei rituali funebri a lei dedicati, e la lamentazione funebre era uno dei più importanti. Solo alla conclusione del periodo del lutto, il morto poteva realmente essere considerato tale.
La necrofobia nata probabilmente con l’uomo sedentario, era timore reale: si temeva che l’anima del defunto potesse tornare, incollerita con i vivi per i tiepidi lamenti a lui riservati. Invocare Vendetta, strapparsi i capelli, disperarsi, graffiarsi, erano segnali che si riteneva il morto avrebbe letto come di dolore sincero.
E’ affascinante voler leggere all’interno della ben strutturata lamentazione funebre ad opera delle donne attitadoras qualcosa di ben più atavico, legando i suoi dettagli simbolici a remoti rituali di generazione. E probabile che dei defunti non si sia avuto sempre timore, la morte d’altronde un tempo doveva essere ritenuta di complemento alla vita. Non si sarebbe spiegato altrimenti perché fosse necessario che il grano scomparisse per avere una nuova rinascita.
La morte ciclica della pianta veniva associata alla morte del Dio che nei tempi dovuti, e con i rituali necessari, sarebbe rinato.
In quest’ottica lo strapparsi i capelli non sarebbe un semplice atto lesionistico a prova del proprio dolore, ma una vera e propria offerta al defunto, che dopo il taglio (morte) potrà rinascere. Offerte di sangue (graffi), pane, grano e cereali li si dovrebbe leggere nella medesima, affascinante ed antichissima ottica. Vendetta venne dopo, come estremo sintomo di vita, affamata di sangue, cantata da improvvisatrici poetiche.
Ricordiamole così, scure come ossidiana, con il busto oscillante in avanti ed indietro, ritmiche ed ipnotiche nel proprio recitativo, con il petto battuto dalle mani ossute, con gli occhi bagnati da una luce straordinaria, e le guance vive d’un rossore selvaggio.