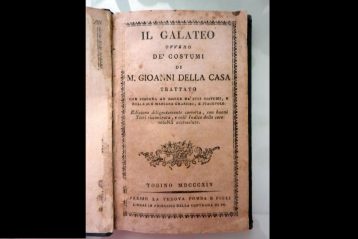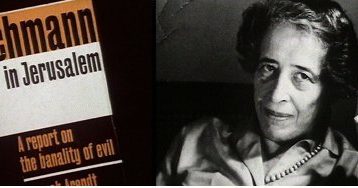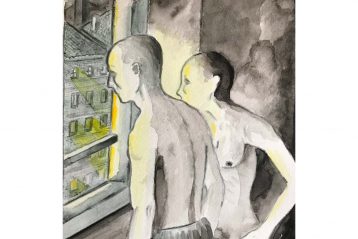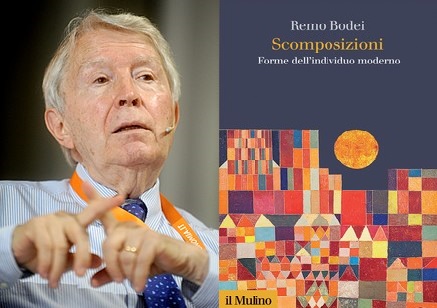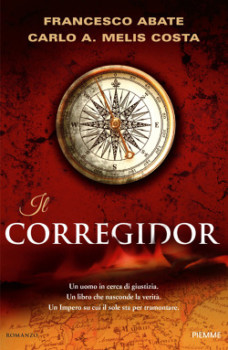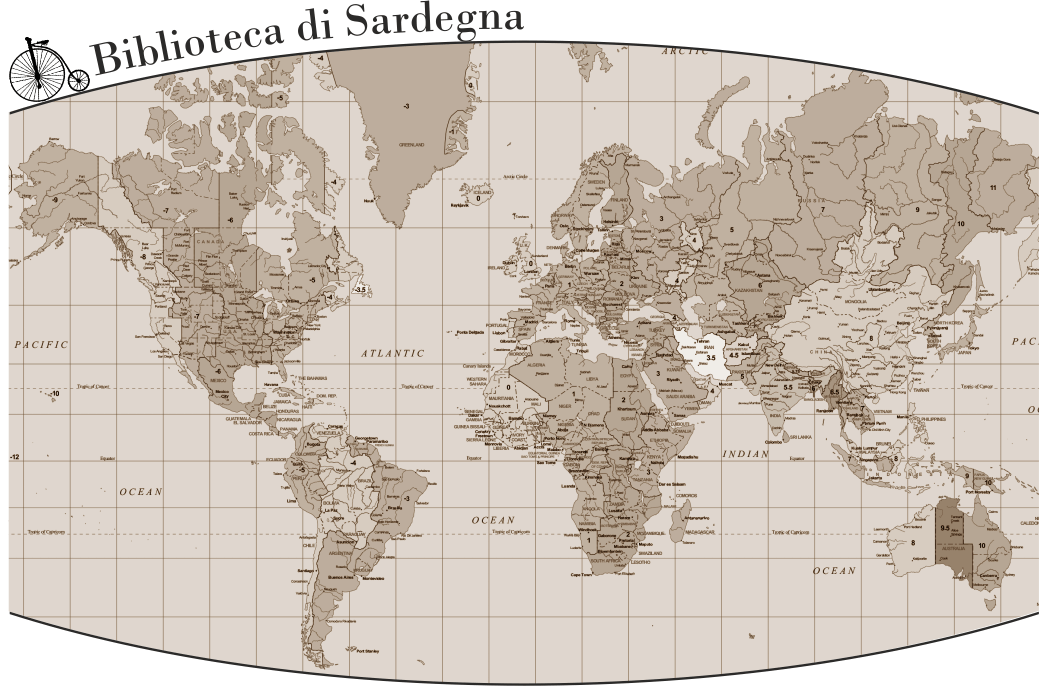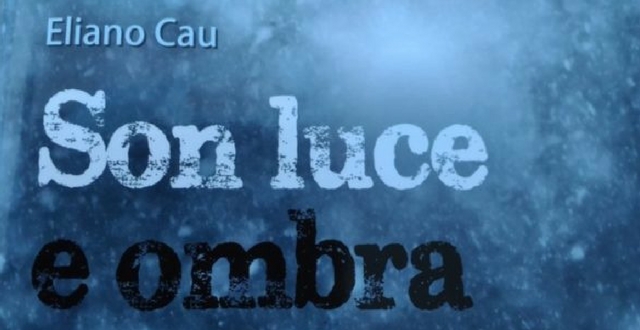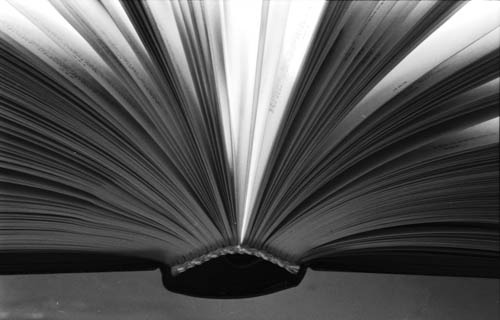“Infine dunque ci mettemmo a tavola con valletti di Alessandria che versavano acqua ghiaccia sulle mani […] Ci fu portato un antipasto molto sontuoso; infatti tutti si erano già messi a tavola tranne Trimalcione, […] si era alle prese con tali delizie quando lui giunse lì trasportato a suon di musica …”1.
Piccolo frammento, questo, simbolo dei lussureggianti banchetti di epoca romana e nello specifico di questo, opulente e fastoso simposio in cui l’ostentazione quasi tracotante del cibo lo fa da padrona; è la tavola del liberto Trimalcione che ospita gli errabondi protagonisti del Satyricon Petroniano, Encolpio ed Ascilto. Un’esuberante ospitalità la sua, finalizzata ad accogliere nel migliore dei modi i propri amici e volta comunque a rimarcare le sue ricchezze. Con un significato simbolico del banchetto che andava oltre il consumo dei viveri, piuttosto il retaggio di un uomo un tempo schiavo che sentiva il bisogno di urlare al mondo la sua conquistata libertà.
Ma questa è solo una delle facce assunte, nella storia delle culture greco-romana ed anche extraeuropee, dell’accoglienza rivolta ad un ospite. C’è tutto un mondo dietro, molteplici sfaccettature talvolta in antitesi tra loro.
L’etimo della parola ospitalità ci svela storie, abitudini e rigide regole strutturali atte a far funzionare – regolamentandoli – i rapporti tra ospite ed ospitante. Percorsi semantici ora congiunti, ora paralleli e testimoni di come e quanto un vocabolo tramandi nei secoli l’assetto di società arcaiche e le loro evoluzioni, seguendole nel tempo.
Il termine di base cui ci si deve riferire è il latino hospes2, derivato dalle due forme congiunte hostis (ospite, colui che compensa un dono con un contro-dono) + *potis che designa l’identità personale (egli stesso, il signore, lo sposo); due termini distinti che andranno a ricongiungersi dal punto di vista semantico. Emerge un concetto legato a quello del “potere” (<lat. possum), che si riaggancia ad una matrice linguistica indoeuropea che significava “suo proprio, di sé”. Un passaggio concettuale (da ‘ospite’ a ‘padrone’) comprensibile solo se riferito ad una cerchia ristretta di persone (clan, tribù) subordinata ad un soggetto centrale dalla personalità catalizzatrice, che assumeva in sé, da solo, l’identità del gruppo.
Ma come arrivare al senso classico di “nemico” che il termine acquisì poi?
C’è un rapporto tra ‘ospite’ e ‘nemico’, spiegabile col fatto che entrambi derivano dal senso di ‘straniero’ (attestato in latino): lo straniero favorevole era l’ospite e lo straniero ostile, il nemico. E nel mondo romano l’hostis non era uno straniero in generale che abitava fuori dal territorio (peregrinus), bensì colui il quale era accettato ed integrato nella civitas, cui erano riconosciuti diritti uguali a quelli dei cittadini romani. Un riconoscimento che presupponeva rapporti di equità ed uguaglianza.
Come non evocare lo stretto parallelismo con la nozione di potlatch3, ben descritta ed analizzata da Marcel Mauss nel suo Saggio sul dono (1923), il sistema di scambi utilizzato nelle arcaiche popolazioni indiane del Nord-Ovest d’America, che investiva tutte le sfere del vivere: sociale, politico, economico, familiare e religioso. Secondo tale sistema l’offerta di qualcosa (cortesie, feste, riti, regali) implicava sempre l’obbligo, per il ricevente, di contraccambiare con un dono ancora maggiore; così, anche il dono dell’ospitalità era solo apparentemente libero e gratuito, in realtà forzato ed interessato. E questo aspetto del fasto come luogo simbolico dell’accoglienza di chi vogliamo con noi, alla pari con noi, cela un particolare (vivo ancor’oggi nelle società occidentali moderne) non trascurabile: un meccanismo di antagonismo tra le parti che, in reciproca rivalità, entrano in una competizione in cui vince chi maggiormente fa sfoggio dei propri averi, chi offre di più e quindi meglio accoglie.
Medesima istituzione esisteva nel mondo greco, la xenìa, che regolava appunto il rapporto di reciprocità obbligatoria tra gli uomini e loro discendenti, realizzato in primis dallo scambio di doni:
“sì, tu sei per me un ospite (xeìnos) ereditario e da lungo tempo […], evitiamo allora entrambi i giavellotti l’uno dell’altro… Scambiamoci piuttosto le armi, così che tutti sappiano qui che ci gloriamo di essere ospiti ereditari”. Così Diomede a Glauco, dopo aver scoperto che i loro padri erano stati legati da vincoli di ospitalità, nel Canto VI dell’Iliade (vv. 120-136).
Il funzionamento del ‘gioco’ dell’ospitalità è tutta una questione di equilibri e rigide norme che lo governano. Una sorta di nomenclatura che caratterizza l’insieme di rapporti tra gli individui, nutriti da aspettative ed aspirazioni, la disattesa dei quali è causa di rottura degli stessi.
Eccedere nei modi dell’accoglienza, perdendo il senso della misura, è una delle cause di tale rottura. Il troppo zelo soffoca l’ospite, gli arreca disagio, lo opprime e toglie naturalezza e spontaneità al transfert che dovrebbe intercorrere tra le parti in maniera del tutto naturale e disinteressata. Ma chi è l’ospite? Certamente un ‘estraneo’ al nucleo familiare che lo riceve, un elemento esterno che va ad inglobarsi negli usi e nelle abitudini di persone che scelgono di aprirsi a lui, mostrandosi senza maschere. L’accezione di ‘estraneo’, in questo caso, non si discosta poi tanto da ‘straniero’: vi è sempre una certa diffidenza, commista all’entusiasmo verso il nuovo, allorquando si accoglie una persona che non ci conosce nel cuore della nostra casa. Ospitare significa rivelarsi, spogliarsi dell’involucro della formalità ed esteriorità.
Un altro elemento fondamentale che regola quest’interscambio è il tempo; l’ospitalità è tale quando ha un inizio e una fine, quando il suo perdurare non è illimitato nel tempo e il suo protagonista, l’ospite, è di passaggio. Viene da fuori, interrompe la nostra ‘solitudine’ familiare, apre una leggiadra parentesi nella nostra routine ma poi, di lì a breve, la chiude andandosene dalla nostra dimora. L’alterazione di queste regole basilari crea alterazione e anomalie.
In letteratura esistono innumerevoli testi che provano quanto sacro fosse considerato l’ospite e di quale aura di mitica ritualità fosse caratterizzato il suo accoglimento.
Basti pensare all’episodio dell’ospitalità rifiutata ai due angeli mandati da Dio a Sodoma e Gomorra – nell’episodio dell’Antico Testamento – che accecarono gli abitanti delle due città offrendo invece protezione al solo che li ospitò, Lot appunto, distintosi addirittura per eccessivo zelo. Una storia, questa, che si può ricollegare a tanti schemi letterari di origine greco-romana: è il topos della “Theoxenìa”, ossia la discesa, in incognito, della divinità tra gli uomini a controllare che la sacra ospitalità fosse rispettata e che la conseguente punizione ai trasgressori fosse inflitta.
E anche Ulisse, di ritorno ad Itaca, è considerato alla stregua di un dio dal suo stesso figlio Telemaco che, inizialmente, non lo riconosce. Fingendosi un mendico, ritorna nei suoi luoghi e la sua venuta è considerata una vera e propria epifania; egli è lo strumento della divinità, mandato a ripristinare l’ordine familiare frantumato, infliggendo una punizione mortale a chi (i Proci), imponendo la propria presenza, ha violato la sacralità dell’ospitalità rendendola coatta e non corrisposta da sua moglie Penelope.
Ulisse è l’ospite ramingo per antonomasia. Il viaggiatore il cui rientro a casa è interrotto e ostacolato da mille vicissitudini. Accolto, sedotto, conquistato, minacciato, costretto, amato, oppresso e adulato riuscirà a far prevalere la sua volontà sulle lusinghe delle donne divine che lo accolgono. Ed è in questi luoghi dell’epos che l’eroe conoscerà anche l’aspetto erotico e sensuale che l’ospitalità femminile può assumere: Nausicaa nel regno dei Feaci gli riserverà un’ accoglienza degna di un re oltre che il suo talamo; la maga Circe, lavatolo e cosparsolo di olii, gli offrirà una sontuosa tavola cui Ulisse, però, non attingerà: la sua ratio saprà dire ‘no’ ai segni di un’ospitalità senza socievolezza, non biunivoca né condivisa. Quella offertagli da Calypso è invece paradigma di un’ospitalità perversa che dà salvezza al naufrago e pretende in cambio la gratitudine eterna: anch’essa forma ‘malata’ di accoglienza, in cui l’ospite invitante vuole appropriarsi, trattenendolo nolente con sé, del suo ospite. Ma Odisseo la rigetterà e con essa anche l’offerta dell’immortalità.
Esiste anche un’architettura dell’ospitalità, spazi della casa deputati al ricevimento di un ospite per metterlo a proprio agio. La casa che accoglie è metafora del corpo; l’esplorazione del labirinto di una dimora è simile a quella di un corpo desiderato: specchi, letti, pitture, profumi, luci possono divenire complici della seduzione che si esercita nei confronti di un ospite.
Ma non sempre la casa e i suoi spazi suscitano in chi la vive positive ed inebrianti sensazioni. Talvolta possono essere forieri di oppressione, stati di cattività, logoramento e alienazione.
Tutto il pensiero di Kafka è imperniato su questo concetto: l’Io violato nella sua intimità dalla convivenza forzata con la propria famiglia, incompreso nella sua volontà di esprimersi, disturbato nelle sue meditazioni dai frastuoni e movimenti chiassosi dei suoi familiari. Un’ospitalità domestica (senza soluzione di continuità e quindi malsana) che lo opprime facendolo sentire ospite indesiderato a casa propria, ostaggio dei propri genitori. Quest’Io che nelle Metamorfosi (1916) è trasformato in un enorme insetto repellente, il cui isolamento sfocerà nella più deprimente alienazione facendolo oggetto di scherno e rifiuto da parte dei suoi stessi familiari e la cui morte sarà auspicata come unica risoluzione al problema.
La casa genitoriale e i suoi spazi di aggregazione, come il salone, sono per lui una prigione, una gabbia: “certo abitare coi genitori è pessima cosa, […] il dibattersi della mosca sulla verga invischiata”4.
Paradossalmente l’autore allo spazio domestico oppone la camera d’albergo, capace di offrirgli una vera ospitalità, in quanto simbolo di passaggio, acquisizione della libertà e conquista del vuoto privo di costrizioni.
Ovunque si trovi sicuro rifugio e calore, là vi è ospitalità.
1. Satyricon, Petronio Arbitro (trad. cap. 30 e segg.)
2. Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, L’ospitalità, E. Benveniste, Giulio Einaudi Editore, pag. 65 e segg.
3. Saggio sul dono, Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, M. Mauss, Einaudi, 2002.
4. F. Kafka, Lettere a Milena in Elogio dell’ospitalità, Alain Montadon, Salerno Editrice, 2002, pag. 217.