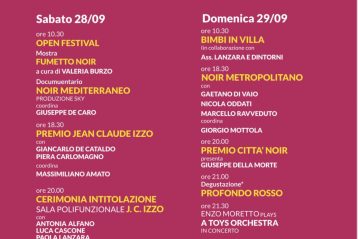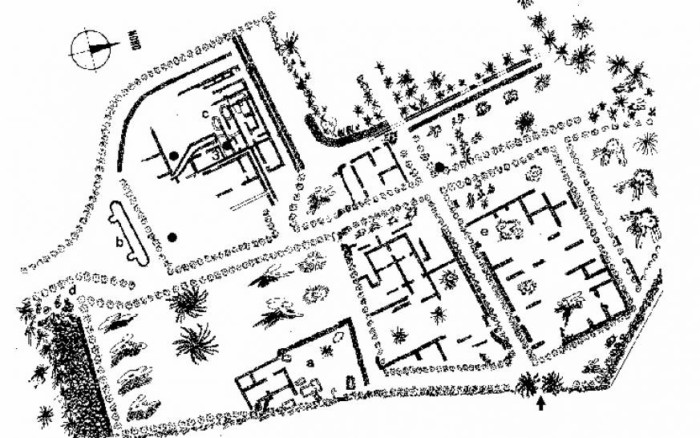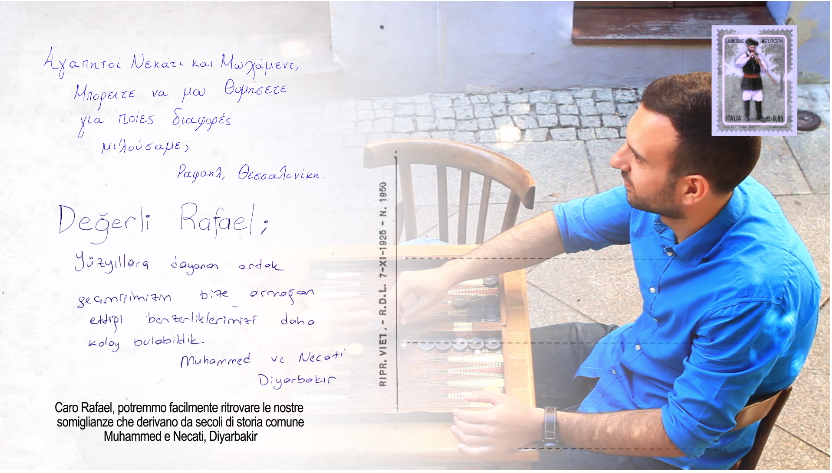«La mia speranza per il futuro è che in occidente riesca ad arrivare un’immagine nuova dell’Iran, un’immagine che dia voce a quelli che sono i problemi più reali e quotidiani del Paese, e spero che questo possa avvenire anche grazie a noi registi, che troppo spesso ci soffermiamo a rappresentare solo alcuni aspetti di una realtà che è molto più complessa». È questo l’augurio che il regista iraniano Zamani Esmati, vincitore con il suo “The Orion” della XVII edizione del MedFilm Festival, ex-aequo insieme all’italiano “Io sono Li” di Andrea Segre, ha rivolto al proprio Paese in occasione della serata di premiazione.
Gli ospiti d’onore di questa edizione sono stati, per la sponda sud del Mediterraneo, Tunisia ed Egitto, teatri, nell’anno ormai trascorso, di sconvolgimenti di portata storica, e per la sponda nord la Romania, una delle più giovani democrazie del vecchio continente. Come è nel suo spirito ormai per tradizione, il Festival ha rappresentato un luogo di incontro e di dialogo fra le differenti realtà che si affacciano sul mare nostrum, affermandosi ancora una volta come rara occasione per entrare in contatto con universi cinematografici spesso sconosciuti al grande pubblico italiano, e si è proposto come momento di riflessione per lanciare uno sguardo sui molteplici panorami mediterranei alla luce di avvenimenti più o meno recenti, per capire a che punto siamo e verso che direzione ci muoviamo.
I conflitti, in modo più o meno palese, hanno fatto da sfondo a molti dei film e dei documentari in concorso. Conflitti intesi nelle loro molteplici accezioni, sia come vere e proprie guerre armate, come rivolte o rivoluzioni, ma anche come lotte personali, con sé stessi o con gli altri, non meno letali nel loro scavare dentro l’animo umano costringendo le persone a mettersi a nudo, fino alla soluzione finale che può essere la redenzione o l’annientamento, e segnando gli individui per anni, a volte per intere generazioni.
Così come avviene nel film vincitore del Festival, che racconta un Iran in cui la censura imposta dal regime post rivoluzionario sembra essere penetrata anche nella parte più recondita delle persone, soffocando le coscienze e trasformando i cittadini in longa manus del sistema stesso. In un quadro del genere è inevitabile che la tragedia sia alle porte, e la drammatica scena finale lascia poco spazio al sogno di cambiamento. Cambiamento in cui non può sperare nemmeno il protagonista di “The mosque”, di Daoud Aoulad-Syad, espropriato della sua terra sulla quale è stata costruita una moschea, parte di un set cinematografico ormai smantellato, che resta in piedi grazie alla connivenza fra il nuovo imam, le autorità locali e il politico di turno, in un affresco che riproduce, in un minuscolo villaggio disperso nella campagna marocchina, l’essenza stessa del mondo arabo (e, forse, del mondo in generale), con le sue lotte, le sue ipocrisie e le sue dinamiche sociali.
Una speranza per il futuro la trasmette invece “Io sono Li”, storia di due mondi diversi che si incontrano per colmare due solitudini, quasi a dire che, più delle differenze culturali, ciò che conta è il ritrovarsi di due persone che, sentendosi entrambe in qualche modo “straniere”, cercano un terreno comune su cui costruire un rapporto vero. Anche nel tunisino “Satin Rouge”, di Raja Amari, il conflitto interiore di una donna in lotta fra la riscoperta della propria femminilità e sensualità attraverso la danza e la prigionia a cui si è costretta dopo la morte del marito, nella cura della casa e della figlia poco più che adolescente, si risolve in modo positivo, con la protagonista che riuscirà a trovare un equilibrio fra la sua felicità e quella della giovane figlia.
I conflitti armati fanno invece da sfondo ad altre pellicole, guerre più o meno lontane nel tempo e nella memoria collettiva, come quelle ormai dimenticate che hanno sconvolto i Balcani, le cui ferite sono però ancora aperte e condizionano l’esistenza delle nuove generazioni. Come dimostra “Sevdah for Karim” di Jasmin Durakovic, il cui giovane protagonista, costretto a vivere una vita segnata dalla guerra (lavora come artificiere sui monti disseminati di mine antiuomo dopo aver perso un piede su una di esse, quando era ancora bambino, e vive con la sorella, l’unico familiare che la guerra gli ha risparmiato), sembra quasi voler cercare la morte quale soluzione ad una vita che non è stato lui a scegliere. O anche “If the seed doesn’t die” di Sinisa Dragin, dove le storie di diversi personaggi (un padre romeno che cerca la figlia venduta come prostituta per le truppe NATO in Kosovo, un altro serbo all’inseguimento del corpo del figlio morto in Romania, un barcaiolo che traghetta clandestini lungo il Danubio) si intrecciano fra la Romania, la Serbia e il Kosovo.
Ci riportano ancora più indietro nel tempo “Beirut hotel” di Danielle Arbid, con una storia che, seppure ambientata nella Beirut contemporanea, richiama, nella trama spionistica e nella diffidenza dimostrata dai personaggi, il clima di sospetto creato dalle lotte fra le diverse fazioni etniche e religiose che sconvolsero il Paese negli anni ’70 e ’80, e “Les hommes libres” di Ismaël Ferroukhi, che racconta la persecuzione degli ebrei marocchini in Francia e l’eroismo dei loro connazionali musulmani che ad essa si ribellarono, sfidando i tedeschi e riuscendo a salvare molte vite.
Ci sono poi le guerre solo apparentemente finite e su cui è calato il silenzio dei media, come quella irachena, di cui parla “Iraq: war, love, god e madness” di Mohamed Al-Daradji, vincitore del premio “Open Eyes” per la sezione Documentari, che racconta le tremende difficoltà incontrate dal regista nel girare un film a Baghdad nel 2004, fra interrogatori, attentati terroristici, arresti e torture.
E infine i conflitti insolubili, come quello fra palestinesi e israeliani, di cui “This is my land… Hebron” di Giulia Amati e Stephen Natanson, guadagnatosi una meritatissima menzione speciale nella sezione Documentari, rappresenta la summa, sottolineando in modo realistico e agghiacciante come, se mai si dovesse arrivare a dirimere lo scontro almeno da un punto di vista politico, rimarrebbe sempre l’odio dell’animo umano che neppure la firma su un trattato può far tacere.
A questo punto c’è da chiedersi che strascico lasceranno le rivolte ancora in corso in diversi Paesi del mondo arabo. Nessuno può prevedere le conseguenze di una situazione ancora in divenire, ma è invece sicuro che i germi di ciò che sarebbe successo covavano già da tempo, come hanno dimostrato i molti film tunisini ed egiziani presenti al Festival. “Laicite inch‘allah” di Nadia El Fani racconta il disagio di molta parte della società tunisina, abituata ormai ad una vita di tipo “occidentale” e che si vorrebbe laica, ma si sente schiacciata e soffocata dal peso dalle catene sociali imposte da chi, sfruttano e distorcendo la religione, vuole imporre restrizioni anacronistiche al solo scopo di esercitare maggiormente il controllo sulle grandi masse popolari. “Hymen national – Malaise dans l’islam” di Jamel Mokni affronta invece il problema attualissimo nella società tunisina, così come in quelle arabe più in generale, della verginità femminile, frutto dell’insicurezza degli uomini che la reclamano al solo scopo di esercitare una sorta di controllo sulle donne. Il problema però non è solo maschile, dal momento che spesso sono le madri a controllare le figlie e a perpetrare un sistema che non ha più ragion d’essere, e il documentario svela tutta l’ipocrisia di una società in cui lo studio e l’ampliamento dei propri orizzonti culturali è inutile, dal momento che le menti sono ancora controllate da tradizioni ancestrali e abitudini ataviche, che non hanno nulla a che vedere con la religione. Devono dunque sentirsi davvero impotenti gli uomini sapendo che ormai una ragazza non più vergine può fare ricorso ad una semplice operazione di ricostruzione dell’imene e fa sorridere il fatto che il loro senso dell’onore derivi da pochi centimetri di pelle…
Alla luce di quanto detto, potrebbe stupire la vittoria in Tunisia del partito alNahda, contro cui si è pesantemente scagliato il regista Jamel Mokni, preoccupato per le conseguenze che questo voto potrebbe avere sul suo Paese, soprattutto a causa della duplicità di un partito strutturato su due livelli: «C’è un livello di superficie, che mostra il suo volto moderato e rassicurante sia in patria sia di fronte al resto del mondo – ha detto Mokni, presente in sala – ma chi impartisce gli ordini è un secondo livello, più nascosto e pericoloso, che è la vera mente del movimento».
La rivolta egiziana è stata invece raccontata attraverso film e documentari, come “The agenda and me” di Neveen Shalabi, che è andata fra la gente di piazza Tahrir durante i giorni più caldi della protesta. E al governo che sosteneva che l’unica agenda pianificata dai ribelli in piazza fosse quella di sovvertire l’ordine del Paese, la gente ha risposto esponendo un programma che chiedeva semplicemente libertà, rispetto, diritti e giustizia sociale. In “18 days” dieci registi hanno collaborato per raccontare altrettante storie ambientate durante i 18 giorni che hanno cambiato la storia recente dell’Egitto, a volte distruggendo le famiglie con la perdita di un figlio, un padre o un fratello, altre trasformando semplici cittadini in eroi. Su tutto però prevale la rappresentazione dei sentimenti espressi dalla gente per strada, il fortissimo desiderio di riprendere in mano le proprie vite e l’orgoglio di poter camminare per le strade sentendosi finalmente cittadini a pieno titolo, liberi di poter esprimere ciò che pensano a voce alta e senza paura.
Un Egitto semi sconosciuto è quello che presenta invece “Microphone” di Ahmad Abballa, guadagnatosi una menzione speciale, interamente girato ad Alessandria nella società dell’arte underground, dei gruppi musicali hip hop e rock, anche femminili, dei graffitisti notturni e degli skater, che sembrano vivere quasi in un mondo parallelo, a cui Khaled, appena rientrato dagli USA dopo una lunghissima assenza, cercherà di dar voce organizzando per loro un vero e proprio concerto che li faccia uscire dall’anonimato dandogli la possibilità di esprimersi liberamente.
“Cairo exit” di Hesham Issawi affronta invece le problematiche sociali che affliggono la società egiziana da decenni, e che costituiscono poi l’humus su cui sono germogliati i semi della rivolta. Le difficoltà della storia d’amore fra Tareq, musulmano, e Amal, cristiana copta, fanno da sfondo a tematiche ormai endemiche: Tareq è deciso a tentare il pericoloso viaggio in barca per raggiungere l’Italia, dopo gli inutili tentativi di trovare lavoro frustrati anche dalla corruzione che dilaga nel Paese; Amal scopre che la sorella Hanan si prostituisce per cercare di arrotondare le entrate familiari e garantire al figlio un futuro che sia migliore di quello che lei ha avuto; un altro tipo di prostituzione è quello dell’amica Rania, decisa a sposare un uomo ricco molto più grande di lei, che non ama, pur di abbandonare la situazione in cui si trova, e da cui riuscirà a farsi regalare, con l’inganno, la cifra necessaria per l’operazione di ricostruzione dell’imene per tornare vergine. Per sfuggire ad una vita fatta di lavoretti saltuari e non finire come Rania o Hanan o come sua madre, vessata da un vicino di casa che finge di corteggiarla per derubarla e picchiarla, Amal decide di seguire Tareq nel pericoloso viaggio, nel quale ci piace vedere una speranza per i due giovani di realizzare i loro sogni e un augurio per il popolo egiziano di riuscire a riappropriarsi del proprio Paese e trovare in esso le opportunità di un futuro migliore, sulla base dei principi urlati durante i giorni della rivolta: «Cambiamento, libertà, giustizia sociale!».